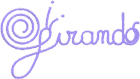Quello
del Pozzo della Cava rappresenta un caso unico nel panorama dei beni culturali
italiani: un monumento nazionale riportato alla luce e gestito direttamente dalla
famiglia che ne è proprietaria. Proprio così, le nove grotte ipogee del Pozzo
della Cava, nel cuore del quartiere medievale di Orvieto, sono state recuperate
e rese visitabili, nel corso degli ultimi venti anni, senza che nessun contributo
pubblico sia mai stato erogato, né per i lunghi e laboriosi lavori di recupero
degli ambienti e dei numerosi ritrovamenti che ospitano, né per la loro promozione
e manutenzione.
La singolarità dell'intera struttura è quella di accogliere
al suo interno un grande numero di ritrovamenti archeologici etruschi, medievali
e rinascimentali gli uni accanto agli altri, quasi stipati nelle grotte che costruiscono
il percorso di visita al pozzo, con secoli di storia accavallati in un susseguirsi
di usi e riusi degli stessi ambienti.
E spesso le nuove scoperte, avvenute
nel corso degli ultimi venti anni hanno aggiunto altre pagine alla storia della
città e rimesso in discussione tesi consolidate.
Nel dicembre del 1984, infatti,
è stato riscoperto il Pozzo della Cava, forse il ritrovamento più imponente dell'intero
complesso, con i suoi 36 metri di profondità e gli oltre quattro di diametro,
scavato seguendo la traccia di un pozzetto etrusco ancora visibile. Fu questo
il primo pozzo realizzato ad Orvieto su commissione di Papa Clemente VII (rifugiatosi
in città dal sacco di Roma nel 1527) e non quello di San Patrizio, come si era
creduto fino al 1999, quando un noto ricercatore orvietano, confrontando date,
editti e scritti di Antonio da Sangallo il Giovane, ha risolto l'equivoco.
Non
meno singolare la vicenda legata alle due fornaci di ceramica rinvenute al pianterreno
delle grotte del Pozzo della Cava, che hanno potuto dimostrare una produzione
di maiolica anche nel XV e nel XVI secolo, ritenuti fino ad allora i periodi bui
della ceramica orvietana, ed hanno iscritto Orvieto tra i pochissimi centri di
produzione dei preziosi "lustri" cinquecenteschi, famosi per l'iridescenza dei
loro colori. E così, continuando a scendere nei sotterranei, tra pozzi-butti medievali
e qualche cunicolo, tra una cisterna etrusca trasformata in cantina e i resti
di una casa-torre duecentesca, si arriva alle ultime grotte del percorso, aperte
al pubblico nell'ottobre 2003, dopo più di un anno di lavori.
A colpire, oltre
all'imponenza di queste "nuove" stanze, la più grande delle quali raggiunge i
14 metri di altezza, è lo straordinario valore dei resti rinvenuti: nonostante
una infinita serie di riutilizzazioni e trasformazioni, infatti, sono ben identificabili
alcune nicchie per urne cinerarie, praticamente identiche a quelle presenti nelle
tombe più antiche di Norchia, nel Lazio. L'eccezionalità di una tale scoperta
sta nel fatto che fino a qualche anno fa non erano mai state rinvenute, in tutto
il territorio, sepolture risalenti al primo periodo di permanenza degli Etruschi
ad Orvieto.
L'ultima sorpresa, in ordine di tempo, risale al 2004, in occasione
dei lavori per il ripristino del grande arco su Via della Cava che nel Rinascimento
costituiva l'unico accesso al pozzo. A ricordare ai cittadini sia la presenza
del pozzo che la sua chiusura, avvenuta cono ogni probabilità in seguito alla
Guerra di Castro, era stata apposta dalle autorità comunali una lapide nel 1646.
Proprio rimovendo quella pietra si è potuto scoprire che l'iscrizione era stata
scolpita sul retro di una spessa lastra di marmo con bellissimi bassorilievi altomedievali,
prelevata dai sotterranei della vicina collegiata dei Santi Andrea e Bartolomeo.
 Quello
del Pozzo della Cava rappresenta un caso unico nel panorama dei beni culturali
italiani: un monumento nazionale riportato alla luce e gestito direttamente dalla
famiglia che ne è proprietaria. Proprio così, le nove grotte ipogee del Pozzo
della Cava, nel cuore del quartiere medievale di Orvieto, sono state recuperate
e rese visitabili, nel corso degli ultimi venti anni, senza che nessun contributo
pubblico sia mai stato erogato, né per i lunghi e laboriosi lavori di recupero
degli ambienti e dei numerosi ritrovamenti che ospitano, né per la loro promozione
e manutenzione.
Quello
del Pozzo della Cava rappresenta un caso unico nel panorama dei beni culturali
italiani: un monumento nazionale riportato alla luce e gestito direttamente dalla
famiglia che ne è proprietaria. Proprio così, le nove grotte ipogee del Pozzo
della Cava, nel cuore del quartiere medievale di Orvieto, sono state recuperate
e rese visitabili, nel corso degli ultimi venti anni, senza che nessun contributo
pubblico sia mai stato erogato, né per i lunghi e laboriosi lavori di recupero
degli ambienti e dei numerosi ritrovamenti che ospitano, né per la loro promozione
e manutenzione.